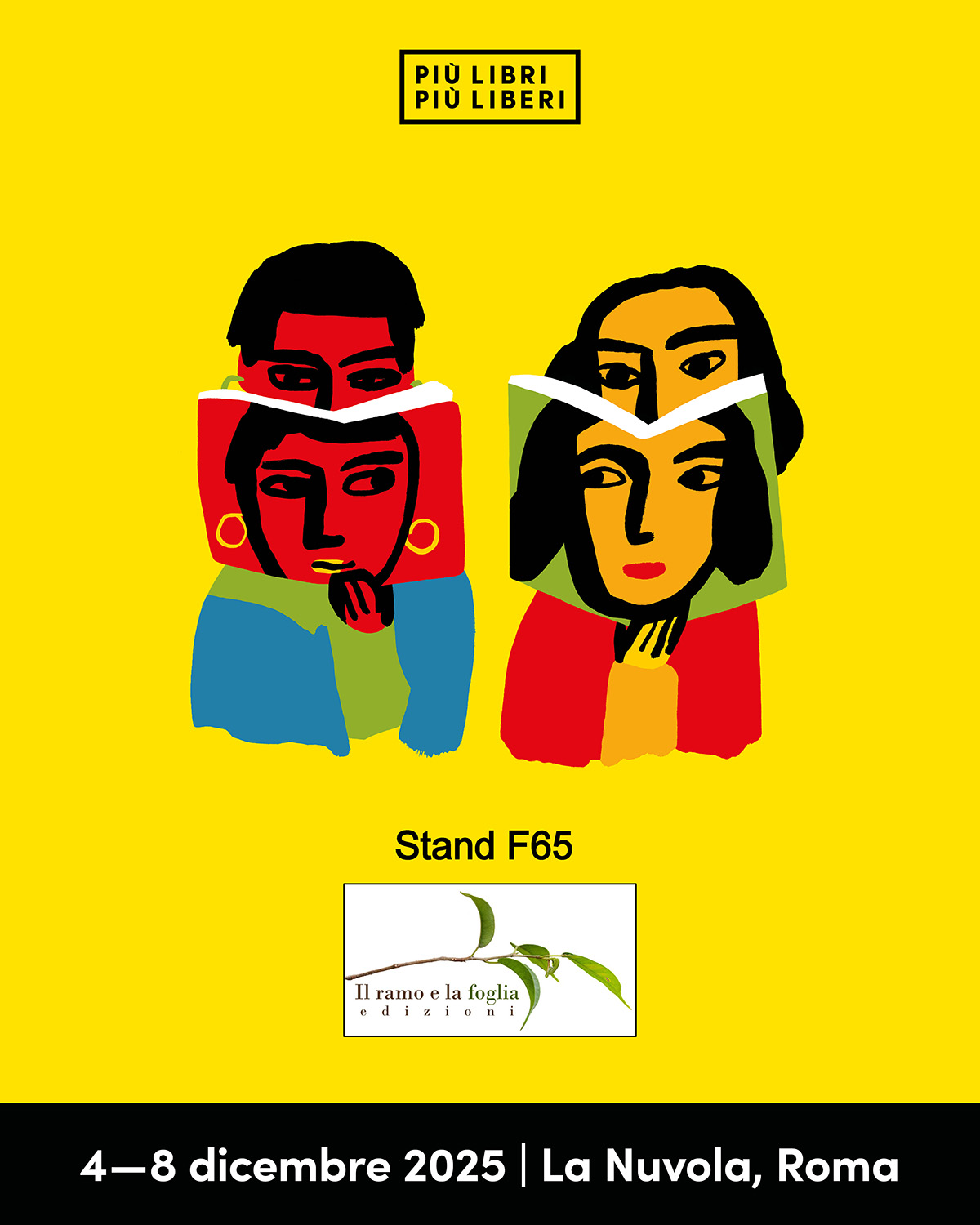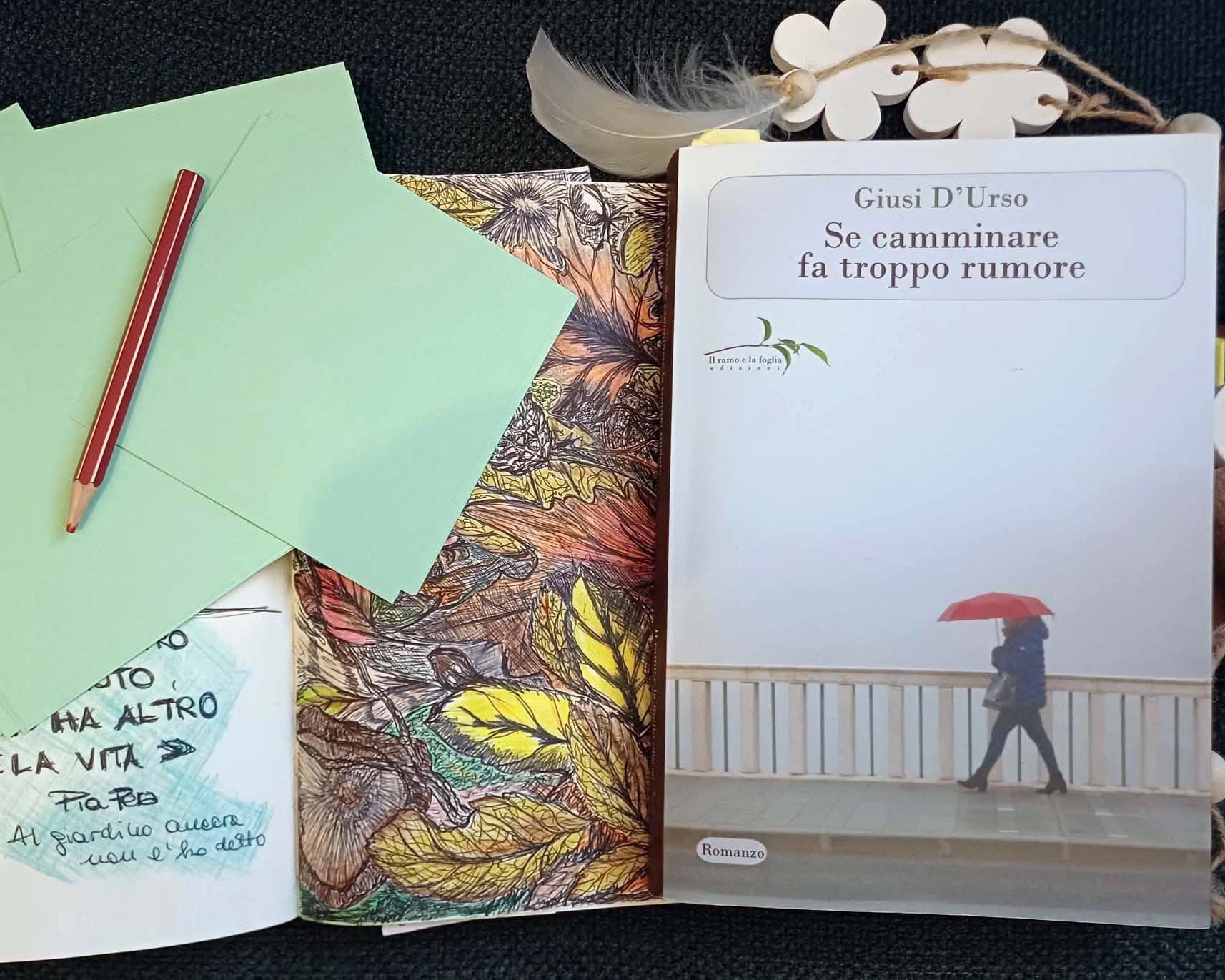Recensione di Giusy Capone
L’Oltre: Eugenio Montale tra filosofia, fisica e religione si presenta come un’indagine dottissima e vertiginosa, un esercizio di pensiero che si accosta alla parola poetica montaliana non con la timidezza del filologo, ma con l’ardire dell’esegeta, come chi riconosce nella poesia non un genere letterario, bensì una forma di conoscenza altra, un’epistemologia dell’enigma. L’opera si muove lungo un crinale sottile e periglioso, là dove la riflessione filosofica incontra le aporie della scienza contemporanea e la nostalgia del divino si coagula in cifra negativa: ciò che Montale chiama “l’ombra che s’infrange sulle carte” diviene qui segnale d’un’ermeneutica dell’invisibile, un sapere franto che si annuncia nella cesura del dire. Il poeta ligure, nella lettura offerta da questo testo, non è mai lirico dell’intimità o cantor del paesaggio: egli è, piuttosto, un filosofo mascherato da funambolo, uno gnostico laico che sa che ogni parola è inadeguata e tuttavia necessaria, ogni rivelazione è un’illusione, ma il silenzio stesso è abitato da echi. L’autrice del saggio, con rigore raro e sensibilità quasi barocca, svela come la poesia montaliana dialoghi sotterraneamente con le inquietudini di un mondo che ha smarrito l’unità del reale, ponendo Montale accanto a pensatori dell’incompiutezza e del limite come Kierkegaard, Pascal, Jankélévitch. L’aspetto, forse, più prezioso dell’indagine consiste nell’intersezione con la fisica: le immagini della dissoluzione molecolare, della luce che si piega, del tempo non lineare, dell’atomo che vibra nell’indeterminazione, non sono meri orpelli metaforici, ma i riflessi stilizzati di un universo che si sfalda nella sua stessa misurabilità. Il “quasi nulla che s’accresce d’eco”, per riprendere un’espressione obsoleta ma felicissima di G. Papini, diventa emblema di una fisica poetica, in cui l’ignoto è l’unico referente stabile. Montale, si legge, è “poeta quantistico”, un ossimoro che qui trova piena legittimazione: come nella meccanica di Heisenberg, anche nei suoi versi ogni osservazione modifica l’oggetto, ogni tentativo di fissare il senso lo dissolve, ogni epifania è contaminata da una zona d’ombra. L’Oltre non è il paradiso dei mistici né il disvelamento gnostico, ma un campo di forze, una membrana sottile tra essere e parvenza: “una fenditura nel muro del reale”, direbbe forse un teologo del primo Seicento. Né manca, in questo volume, un raffinato discorso sulla religione, o meglio sulla sua sparizione auratica: il Dio di Montale è l’absconditus dei salmi medievali, ma svuotato di promessa salvifica, una deità in fuga, un principio che si nega apparendo, che si afferma nel suo sottrarsi. Così, la poesia diventa liturgia laica, sacramento d’una presenza negativa: “Dio che non esisti e che tuttavia / è il solo a cui si giunge / traverso il nulla”, come egli scrive con sublime impudicizia teologica. L’autore del saggio mostra, con un lessico che non teme l’arcaismo e con un gusto quasi manierista per le citazioni recondite, come la poesia montaliana si collochi in una linea di pensiero che parte dal neoplatonismo cristiano, passa per la teologia apofatica di Gregorio di Nissa e culmina nel silenzio aurorale di Simone Weil: in quest’ultima, così come in Montale, il vuoto non è mancanza, ma luogo d’attesa, culla dell’inesprimibile. L’Oltre, in ultima analisi, ci consegna un Montale inatteso, più affine ai matematici dell’invisibile e ai monaci del dubbio che ai poeti elegiaci: una figura ieratica e scabra, che interroga l’universo senza attendersi risposte, che ascolta il fruscio del nulla come unico canto possibile. Un poeta non della speranza, ma del desiderio; non del senso, ma del segno; non del dogma, ma della frattura. E in questo, profondamente, irrimediabilmente contemporaneo.
📖 visita la pagina del libro
Notizie » Giusy Capone: L’Oltre: Eugenio Montale tra filosofia, fisica e religione
Recensione [Libri] 01/04/2025 17:40:12